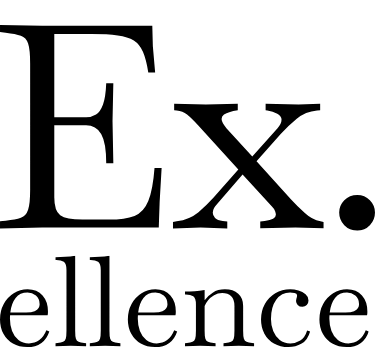Le forze nascoste che mantengono in vita strategie fallimentari
Molte organizzazioni continuano a seguire strategie fallimentari nonostante le evidenze contrarie. Pregiudizi cognitivi, inerzia istituzionale e l’illusione del controllo impediscono il cambiamento. Superare questi ostacoli richiede umiltà epistemica, processi decisionali strutturati e distacco della leadership. Le aziende migliori abbandonano i fallimenti prima che diventino crisi. Se giustificare una strategia richiede più sforzo che eseguirla, è ormai obsoleta.
LEADERSHIP
2/17/20254 min leggere


Nel mondo della strategia aziendale, è allettante credere che il processo decisionale segua un percorso razionale, in cui le prove empiriche determinano le azioni e le strategie fallimentari vengono rapidamente abbandonate a favore di alternative superiori. Tuttavia, la realtà dipinge un quadro diverso. Ancora e ancora, le organizzazioni persistono in approcci strategici che i dati empirici hanno da tempo reso insostenibili. Perché? La risposta non risiede in una mancanza di informazioni, ma in barriere filosofiche, cognitive e istituzionali più profonde e spesso irrazionali che ostacolano il cambiamento strategico.
La persistenza delle strategie fallimentari: un dilemma cognitivo e filosofico
In teoria, le aziende dovrebbero funzionare come decisori bayesiani, aggiornando continuamente le loro convinzioni in base a nuove evidenze. Nella pratica, però, si comportano più come paradigmi kuhniani, dove un quadro strategico esistente non viene facilmente abbandonato, nemmeno di fronte a una smentita schiacciante. Il concetto di "cambiamento di paradigma" di Thomas Kuhn (1962) nelle rivoluzioni scientifiche è estremamente rilevante: proprio come gli scienziati resistono all'abbandono di una teoria dominante fino a quando una crisi non impone un nuovo modello, i leader aziendali spesso si aggrappano a una strategia fallimentare fino a quando i danni non diventano irreversibili.
Questa riluttanza non è solo un pregiudizio cognitivo, ma è radicata nella sicurezza ontologica, un termine sociologico che descrive il bisogno di continuità nel concetto di sé di un individuo o di un'organizzazione. La strategia non è solo un insieme di decisioni, ma un'identità, una visione del mondo e una storia che i leader raccontano su se stessi e sulla loro azienda. Cambiare strategia, quindi, non è solo un passaggio operativo, ma anche esistenziale.
Tuttavia, è importante riconoscere che non tutta la resistenza al cambiamento è irrazionale. La storia dimostra che alcune delle strategie di maggior successo, come l'impegno costante di Apple per prodotti premium in un’epoca di riduzione dei costi, hanno avuto successo perché i leader hanno resistito alla pressione di conformarsi alle tendenze dominanti. La sfida sta nel distinguere tra una persistenza visionaria e un radicamento cognitivo.
La fallacia del costo irrecuperabile e l'inerzia istituzionale
A un livello più pragmatico, la teoria economica offre una spiegazione ben nota ma spesso ignorata: la fallacia del costo irrecuperabile. I decisori, invece di valutare razionalmente le prospettive future, permettono agli investimenti passati—finanziari, emotivi e reputazionali—di dettare le scelte attuali. La Teoria del Prospetto di Kahneman e Tversky (1979) fornisce un’ulteriore intuizione: le perdite pesano psicologicamente più dei guadagni, portando le organizzazioni a raddoppiare gli sforzi su strategie fallimentari piuttosto che affrontare il dolore immediato di riconoscere un errore.
Ma oltre ai pregiudizi individuali, le organizzazioni soffrono di inerzia istituzionale, una resistenza strutturale al cambiamento radicata nei modelli di governance, nelle strutture di incentivazione e nella cultura aziendale. Anche quando le prove supportano inequivocabilmente un cambiamento strategico, le dinamiche di potere e gli interessi consolidati all'interno dell'organizzazione creano resistenza. Coloro che hanno progettato e promosso la strategia esistente spesso hanno più da perdere nell’ammettere il proprio fallimento, portando a un’escalation dell’impegno invece di una correzione razionale del corso.
Gli esempi concreti abbondano. Kodak, nonostante abbia inventato la fotografia digitale, ha fallito nel passare oltre il proprio business della pellicola a causa di investimenti profondamente radicati nella sua strategia tradizionale. Nokia, un tempo leader nel settore della telefonia mobile, ha faticato ad adattarsi alla rivoluzione degli smartphone a causa di una cultura interna che ha resistito ai cambiamenti necessari. Questi casi dimostrano come persino i leader di mercato possano cadere vittima delle trappole psicologiche e istituzionali che inibiscono il cambiamento strategico.
L'illusione del controllo e il mito del leader visionario
Un’altra barriera filosofica è la profonda convinzione nell'agenzia strategica, l'idea che la leadership e la visione possano prevalere sulle realtà esterne. Molti dirigenti aderiscono a un modello nietzschiano di leadership, in cui il leader determinato impone la propria visione al mercato anziché adattarsi ai vincoli esterni. Questa illusione di controllo è rafforzata dalla mitologia aziendale: celebriamo gli outsider che hanno sfidato le probabilità e liquidiamo come "sfortunati" coloro che hanno fallito nonostante seguissero una logica strategica solida.
Il Dilemma dell’Innovatore di Clayton Christensen (1997) fornisce un esempio calzante: molte aziende falliscono non perché non siano consapevoli dei cambiamenti nel settore, ma perché i loro leader credono di poter aggirare le forze strutturali con pura determinazione ed esecuzione. BlackBerry, ad esempio, ha mantenuto il suo focus sulle tastiere fisiche e sui clienti aziendali ben oltre il punto in cui gli schermi touch e il mercato consumer erano diventati la norma, convinta che la sua identità di brand potesse sfidare le preferenze in evoluzione dei consumatori.
Riconoscere i vincoli esterni non significa che i leader debbano abbandonare una visione ambiziosa. Piuttosto, sottolinea l’importanza della flessibilità strategica, bilanciando la convinzione con la capacità di adattarsi ai cambiamenti della realtà.
Liberarsi dalle catene: superare le barriere al cambiamento strategico
Se gli ostacoli al cambiamento strategico sono così profondamente radicati, come possono essere superati? La risposta non è né puramente razionale né puramente emotiva, ma richiede una sintesi di umiltà epistemica e meccanismi strutturali:
Scetticismo Istituzionalizzato: Ispirandosi al falsificazionismo di Karl Popper, le organizzazioni dovrebbero progettare meccanismi in cui le strategie esistenti debbano continuamente dimostrare la loro validità, invece di essere considerate corrette fino a prova contraria.
Distacco della Leadership: I consigli di amministrazione e i dirigenti devono riconoscere che i framework strategici sono strumenti, non identità. Proprio come nella scienza, i modelli devono essere aggiornati, non venerati.
Architettura Decisionale: Separare le persone che valutano le prestazioni strategiche da quelle che hanno ideato la strategia riduce il pregiudizio personale nelle valutazioni.
Analisi Pre-Mortem: Le ricerche di Gary Klein suggeriscono che immaginare un futuro in cui l'attuale strategia ha fallito può aiutare a superare i pregiudizi rendendo il fallimento tangibile prima che si verifichi.
Benchmarking Esterno: Osservare come i concorrenti o settori affini hanno affrontato con successo sfide simili può fornire spunti preziosi e ridurre l’eccessiva fiducia nell’unicità del proprio approccio.
Un rasoio strategico
La difficoltà nell’abbandonare strategie fallimentari non è un fallimento dell’intelligenza o dell’analisi, ma un riflesso di forze filosofiche, cognitive e istituzionali più profonde. Comprendere queste barriere è il primo passo per superarle. Le migliori organizzazioni non sono quelle che non falliscono mai, ma quelle che riescono ad abbandonare i propri fallimenti prima che diventino crisi esistenziali.
Proprio come il Rasoio di Occam favorisce la semplicità nelle spiegazioni, si potrebbe formulare un utile Rasoio Strategico: se mantenere una strategia richiede spiegazioni sempre più complesse anziché un’esecuzione semplice e risultati concreti, è il momento di riconsiderarne la validità.
Coltivando una cultura dell’adattabilità, le organizzazioni possono garantire che le loro strategie evolvano in sintonia con le realtà del mercato—prima che sia troppo tardi.